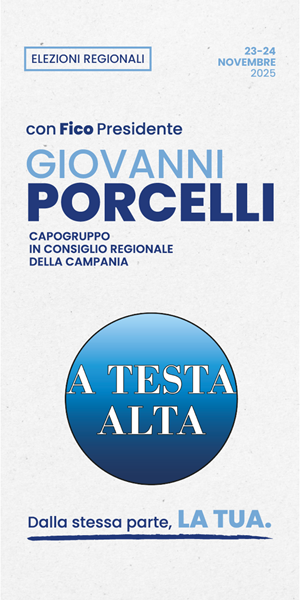«Quando esco mi capita di vedere nel mio quartiere grandi mappaglie di persone che spacciano, ma a noi della zona ci proteggono». Anna, tredici anni, racconta con disincanto la vita tra Miano e Scampia, in quel triangolo della morte teatro di una guerra di camorra che ha prodotto settanta vittime. Scuola media Salvo D’Acquisto, Miano. L’istituto è lo stesso dove i ragazzi hanno realizzato un fotoromanzo anticamorra per dire no alla criminalità e alle violenze striscianti che spesso subiscono per il solo fatto di vivere e studiare nel loro quartiere. Ora, nei temi in classe, sono ancora i clan ad essere protagonisti. Squarci di verità nei loro elaborati. Utili anche a comprendere le logiche delle bande, che per Anna, tredici anni, sono semplici e chiare: «Se qualcuno di un’altra zona avesse l’intenzione di farci del male o di ricattarci – scrive la bambina in un tema – loro ci difendono, ma se c’è tra loro una discussione non guardano in faccia proprio a nessuno e ci vanno di mezzo anche persone innocenti». I bambini guardano, osservano. Alberto spiega le vite bruciate meglio di un trattato di sociologia: «La camorra a Miano c’è e noi la conosciamo bene perché si svolge tutto davanti a noi come per esempio a spacciare la droga che è una cosa che noi vediamo tutti i giorni. Molti ragazzi cominciano a spacciare a 13 anni diventano più importanti e una volta che ci sei entrato non ne esci più e se provi a uscirne vieni ucciso». Per Antonio, stessa scuola, la malavita ha anche degli aspetti positivi: «Nel mio quartiere – scrive – vedo di tutto, come droga, spacciatori, ecc. Ma non mi spavento. Noi cittadini ci siamo abituati. C’è gente che odia la camorra, io invece no, anzi a volte penso che senza la camorra non potremmo stare perché ci protegge tutti, pure il fatto del tutti pagano il pizzo non è giusto, ma chi paga resta protetto». E poi: «Quando scendo vedo bambini, perché sono bambini che spacciano, in grandi macchine, uno qualsiasi che lavora non se lo può permettere». Spaccio, pizzo, rapine, agguati: nei racconti lucidi e senza incanto dei bambini le periferie diventano luoghi dove tutto è possibile. Racconta Francesco: «Nel mio parco una sera spararono con la pistola a piombino e colpirono mia madre, anche un paio di anni fa stavamo un una farmacia, entrò un rapinatore e si prese tutti i soldi dalla cassa e la collanina d’oro di mia madre». C’è anche chi riconosce i propri vicini di casa in tv: sono gli autori dei gesti più efferati: «Quando esco con le mie amiche – racconta Elisa – vedo ragazzi che sui motorini sembrano i padroni del quartiere e a volte riconosco persone che escono sui giornali o nei telegiornali». È soprattutto l’arroganza delle sopraffazioni quotidianamente subite a colpire i ragazzi. Spiega Giovanni: «La cosa che mi dà fastidio è quando i figli di quelli grossi fanno i buffoni, ma alla fine sono nessuno perché sono bambini viziati. Nel mio quartiere si fanno le rapine alle ragazze e le borse le vengono a svuotare da noi e non capisco perché». Annalisa usa l’arma dell’ironia: «Ore 8: scendo per recarmi a scuola. Sotto casa c’è un biliardo. Come mi dà fastidio! C’è tanta gente con la faccia che non mi piace, e la sera vedo che si scambiano dosi sotto al mio balcone, mia madre mi chiede di andare a buttare la spazzatura e mi trovo una montagna più alta di me. Se decido di uscire le mie amiche non portano il casco perché si guastano i capelli e se mi fermo al rosso rischio di farmi tamponare perché al semaforo è vietato fermarsi». Alla D’Acquisto c’è una biblioteca intitolata ad Attilio Romanò, vittima innocente della faida: tutti gli studenti conoscono la sua storia e, finalmente, sono tutti d’accordo: non è giusto morire così, «solo perché ci si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato», come scrive Marco.
DANIELA DE CRESCENZO
Il Mattino il 21/04/08
Vince la malavita perchè da risposte
Per nulla stupito, abituato a confrontarsi con l’istinto dei più giovani, di chi riesce a trarre simboli e immagini anche da una realtà difficile come quella delle Vele e dei palazzoni di periferia. Padre Fabrizio Valletti, rettore gesuita della chiesa Santa Maria della Sparanza di Scampia, la periferia napoletana la conosce bene. Ne conosce il battito, le aspirazioni, le frustrazioni, a partire proprio dal contatto con i più giovani. Padre, uno studente di Miano definisce la camorra come una forma di protezione. Un altro racconta che chi spaccia diventa importante e lo si ritrova subito in sella a uno scooter nuovo di zecca. Qual è il suo commento? «Non mi meraviglia. Sono elaborazioni del vissuto giovanile. Il sistema criminale di cui parliamo fornisce risposte concrete, spesso garantisce stabilità economica e punti di riferimenti territoriali. Bisogna partire da queste analisi, per moltiplicare punti di aggregazione e centri di formazione permanenti nelle aree di periferia». Per un altro ragazzino i pusher sono dei punti di riferimento, quasi un codice di orientamento in una zona desolata come Miano. È un eccesso di rappresentazione fantastica? «Non è un eccesso, ma un’inevitabile rielaborazione del proprio vissuto quotidiano». Qual è la risposta a questo tipo di scenario? «Le rispondo con un esempio: se nella periferia settentrionale ci fossero teatri, centri musicali, complessi sportivi, piazze di vita quotidiana e non di spaccio, laboratori di formazione, scuole sempre aperte e ricettive, forse un ragazzino di dodici anni non dovrebbe fare ricorso alla presenza di un pusher per orientarsi nel proprio contesto». Da dove cominciare, secondo lei? «Dal pomeriggio». In che senso? «La scuola in periferia fa bene il proprio compito. Il problema è che le risorse non sono affatto infinite e non si può pretendere che con i mezzi a disposizione ci siano sempre istituti aperti e pronti ad erogare formazione». Quindi? «Con la mia associazione ”Hurtado”, stiamo cercando di realizzare un modello che riteniamo universale: puntare sui diplomati e laureati di ogni quartiere, sensibilizzarli, insegnare loro la strada della formazione, fare in modo che non lascino il territorio, ma provino a valorizzarlo. La sfida è questo: formare i giovani, con i giovani che ce l’hanno fatta». l.d.g.
Il Mattino il 21/04/08