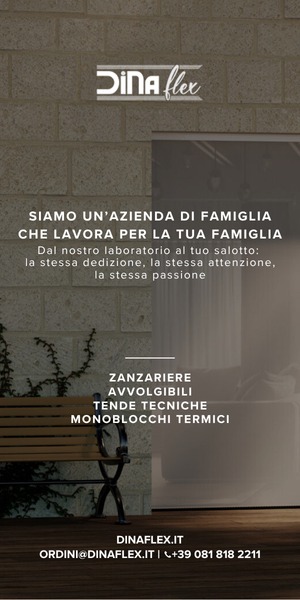Federico Aldrovandi nasce a Ferrara il 17 luglio 1987. È un ragazzo come tanti: ama la musica, lo sport, le uscite con gli amici. Figlio unico, cresce in una famiglia semplice e serena. Frequenta il liceo scientifico “Roiti” della sua città, con la curiosità e le incertezze tipiche dei suoi 18 anni.
Dietro quell’adolescenza normale, nessuno avrebbe immaginato che Federico sarebbe diventato, suo malgrado, un simbolo delle battaglie per la giustizia e contro gli abusi di potere.
La notte del 25 settembre 2005
Nelle prime ore del mattino, Federico sta tornando a casa dopo un concerto a Bologna. Intorno alle 6, una residente in via Ippodromo, insospettita dalle sue urla, chiama le forze dell’ordine. Sul posto arrivano due pattuglie della polizia: quattro agenti in totale.
Quello che dovrebbe essere un semplice intervento di controllo degenera rapidamente in violenza. Gli agenti usano i manganelli con tale forza da spezzarne due. Colpiscono Federico più volte, lo immobilizzano a terra in posizione prona e lo ammanettano. In quelle condizioni, la respirazione diventa sempre più difficile fino all’arresto cardiaco.
Quando i sanitari del 118 raggiungono il luogo dell’intervento, Federico non respira già più. Dichiarano il decesso sul posto. Il referto autoptico e le successive sentenze confermano che la causa della morte è un’insufficienza cardiaca acuta, legata allo sforzo della colluttazione e alla posizione di contenimento. Le perizie rilevano decine di lesioni compatibili con un pestaggio.
La famiglia scoprirà la tragedia soltanto a tarda mattinata. Negli anni successivi i quattro agenti coinvolti – Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani e Monica Segatto – verranno condannati in via definitiva a tre anni e sei mesi di reclusione per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi.
La battaglia per la verità
All’inizio la vicenda viene raccontata in modo distorto. Le prime comunicazioni ufficiali parlano di un “malore” e sottolineano la presenza di sostanze nel sangue del ragazzo, insinuando che la morte derivi da un abuso di droghe. Quel racconto sposta l’attenzione dalle responsabilità dirette e prova a ridurre il caso a un episodio sfortunato.
In questo contesto inizia la battaglia dei genitori, Patrizia Moretti e Lino Aldrovandi. Non si rassegnano a una spiegazione parziale e, tra silenzi istituzionali e tentativi di depistaggio, chiedono con forza chiarezza. Grazie alla loro ostinazione, sostenuta da avvocati, giornalisti e associazioni per i diritti civili, la verità emerge.
Le indagini rivelano un quadro molto diverso: Federico non muore per un malore, ma per le percosse subite e per la modalità brutale con cui viene immobilizzato. Le perizie parlano chiaro: decine di lesioni, due manganelli spezzati, una posizione a terra che gli impedisce di respirare. La sua morte non è una fatalità, ma la conseguenza di un uso eccessivo e sproporzionato della forza da parte degli agenti.
La memoria viva e collettiva
Il nome di Federico Aldrovandi è diventato negli anni sinonimo di resistenza civile. Ogni 25 settembre si tiene una commemorazione e molte piazze, strade e murales in Italia ricordano la sua vicenda. La sua storia ha acceso un faro su un tema scomodo: gli abusi commessi da chi indossa una divisa, il silenzio istituzionale che spesso segue, e il dolore delle famiglie costrette a lottare non solo per la verità, ma per la dignità dei propri figli.
Ricordare Federico significa anche guardare oltre la sua vicenda personale. La sua morte ci spinge a riflettere sugli abusi di potere che si ripetono in contesti diversi e che, in modo intersezionale, colpiscono con più forza chi appartiene a categorie marginalizzate: giovani, donne, persone migranti, poveri, soggettività LGBTQIA+, chiunque si trovi privo di strumenti o reti di protezione. In questi casi la divisa non è solo quella della polizia: può essere quella di un’istituzione scolastica che discrimina, di un sistema sanitario che non ascolta, di un ambiente di lavoro che sfrutta.
L’abuso segue la stessa logica: trasformare la vulnerabilità in colpa, ridurre il dolore a devianza, giustificare la violenza come ordine.
La storia di Federico, dunque, non è isolata. È parte di una trama più ampia di soprusi, negazioni e silenzi. Onorarne la memoria significa ribadire che la giustizia non è solo un fatto processuale, ma una pratica sociale che riguarda tutte e tutti.
Come ha detto sua madre Patrizia:
“Mio figlio non è morto per caso. È morto perché quattro adulti, quattro agenti di polizia, hanno scelto di usare violenza.”