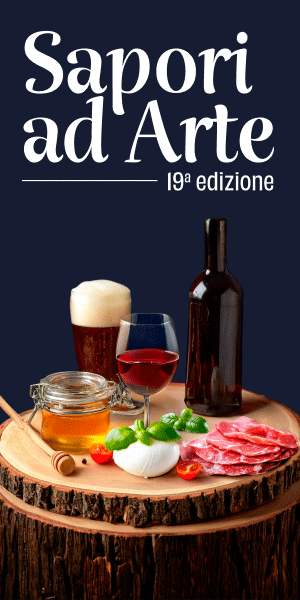ROMA. È il quesito più discusso: dal problema dell´identità del bambino, al nuovo rapporto tra i due genitori
«Non avranno i suoi occhi, non avranno il colore dei suoi capelli, ma hanno il suo sorriso. E mio marito quando sta con loro è felice. Siamo una famiglia felice». Lo dice Federica, una giovane mamma che ha avuto due bambini con le tecniche di fecondazione eterologa (cioè con gamete, sperma o ovocita, da donatore) a causa di una forma grave di sterilità del marito. È la prova migliore che impedire per legge tale tecnica è un «ordine impossibile». Chi non può farlo in Italia lo fa all’estero, se le condizioni economiche lo consentono.
1. Perché una coppia decide di ricorrere alla donazione di gameti?
È sicuramente difficile per la coppia maturare questa decisione(…) anche per ragioni sociali; ma in alcuni casi di grave sterilità di uno dei due è l’unico modo per procreare. Bisogna anche dire che la scelta è frutto di una elaborazione profonda, compiuta insieme, di un progetto parentale che consente di superare le difficoltà psicologiche e le resistenze ambientali e dà solidità alla famiglia. Le statistiche registrano questa maggiore coesione coniugale: le famiglie con figli nati con donazione di gamete sono più durature e solo l’1% va incontro al divorzio.
2.Vi è chi sostiene che il bambino nato da eterologa possa avere problemi di identità.
Ma l’identità di una persona non ha una base esclusiva o prevalente nel patrimonio genetico. L’identità si costruisce nella socialità, nelle relazioni affettive e parentali. Pensare che sia invece esclusivamente il patrimonio genetico a determinare la personalità di un individuo significa ricadere in un banale determinismo e in un materialismo vecchio stampo.
3. Può avere problemi psicologici?
Tutti gli studi compiuti negli anni lo escludono. Si tratta di bambini con una crescita che non comporta problemi specifici. Sono bambini molto desiderati e a lungo cercati e dunque carichi di affetto e di attenzioni, come lo sono spesso i figli unici o attesi a lungo.
4. C’è chi sostiene che vi sia un diritto a conoscere le proprie radici genetiche.
Occorre distinguere fra questione di principio e casi specifici. In casi di particolari malattie che rendano necessarie conoscenze storiche sul proprio patrimonio genetico, quasi tutte le legislazioni prevedono che si possa rendere nota l’identità del donatore o della donatrice tramite l’intervento di un giudice che lo autorizzi. Per quanto riguarda la questione di principio, direi che si tratta di un diritto secondario rispetto ad altri diritti. Rispetto, ad esempio, al diritto alla libertà riproduttiva, a realizzare la propria personalità anche attraverso la procreazione. Non può trattarsi di un diritto universale. I bambini abbandonati, ad esempio, non potranno mai conoscere la loro storia genetica. Inoltre, addirittura un articolo della stessa legge 40 prevede che essa venga violata quando prescrive che l’uomo non può disconoscere un bambino nato da fecondazione eterologa col suo esplicito consenso.
5. Alcuni obiettano che in questo modo si mina la famiglia basata sul legame di sangue.
La consanguineità è importante, ma non è l’unico fondamento del legame familiare.
6. Se accettassimo questa premessa e portassimo la posizione all’estrema conseguenza, dovremmo non riconoscere legittimità alle famiglie con figli adottati. E invece, una grande conquista culturale e di civiltà è l’accettazione di una pluralità di modelli familiari: vi è la famiglia mononucleare, ma anche quella allargata o ricomposta configli provenienti da precedenti matrimoni, quella affidataria e adottiva, con bambini che provengono da altri paesi e da altre etnie. È cambiata anche la cultura della genitorialità: a quella biologica si accompagna in maniera sempre più diffusa quella sociale.
In realtà, col richiamo alla consanguineità come fondamento esclusivo del legame familiare si impedisce alle coppie con problemi gravi di sterilità di creare una famiglia.
7. Ma non dovrebbe esserci un limite al desiderio, anche al desiderio di avere un figlio?
Intanto, dobbiamo tenere conto del fatto che stiamo parlando del desiderio più umano che possa esistere: il desiderio di avere un figlio. Quale donna o quale uomo non lo ha desiderato in un qualche momento della sua vita? Per quel che riguarda il limite, io sono una sostenitrice dell’etica della responsabilità e della cultura del limite. Ma in un campo che attiene alla sfera delle scelte riproduttive, cioè della sfera più intima e privata, il limite non può essere imposto per legge. Non può esserlo sia perché uno stato liberale non può invadere quella sfera e deve ritrarsi, sia perché è un divieto che può essere facilmente disatteso andando all’estero. Non vi è nessuna legge al mondo che vieti l’eterologa. Con la legge 40 siamo diventati un’isola infelice in Europa.
8. E cosa si risponde a coloro che suggeriscono alle coppie con problemi di sterilità di adottare anziché ricorrere all’eterologa?
Che adozione e tecnica eterologa sono due percorsi diversi, che richiedono diversi atteggiamenti e percorsi di elaborazione soggettiva. Vi sono coppie che passano più facilmente dall’uno all’altro quando i tentativi di fecondazione assistita falliscono, per altre il passaggio è difficile o impossibile. Per loro è più accettabile il ricorso alla donazione di gamete. Sono scelte che vanno rispettate.
9. Nel caso dell’eterologa si ha una genitorialità per metà biologica e per metà sociale.
Nel caso di un bambino con gamete da donatore si ha una genitorialità mista, che contiene l’aspetto biologico e quello sociale e relazionale insieme. Alcuni traggono forza e solidità anche da questa complessità. Ma io credo che vi sia un’altra motivazione importante: il fatto che la fecondazione eterologa mantiene la nascita. E la nascita è un evento straordinario nella costruzione di una famiglia, al quale difficilmente si rinuncia.
da L’Unità – 16/05/05