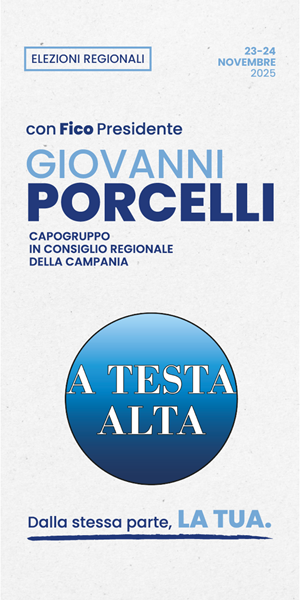NAPOLI. Sembrano passati moltissimi anni, ma sono appena sei. All’epoca tenevo laboratori di scrittura interculturali per un’associazione napoletana con un’amica giornalista, Laura Guerra. Laura aveva da poco scritto per l’Istituto Orientale un bell’articolo che tracciava una mappa delle comunità straniere presenti a Napoli dalla quale si desumeva una forte maggioranza nord africana ma già allora avevamo come partecipanti ai corsi di scrittura un’utenza molto varia: donne eritree ed etiopi – e le presenze convivevano a dispetto della guerra che devastava da anni i reciproci paesi, anzi c’era una sintonica allegria nella classe -, islamici molto ortodossi che non ci davano la mano perché eravamo donne e preferivano non si ascoltasse musica durante la lezione, algerini coltissimi e politicamente perseguitati, una ragazza cinese silenziosa, un paio di sudamericani, un giovanissimo albanese, che molto ci preoccupava con i suoi racconti d’armi nel paese d’origine, un coltissimo giudice etiope e tante altre persone. Quell’anno morì uno dei soci dell’associazione, un giovane ballerino ivoriano, e tutti andammo al funerale che si teneva ai Bipiani, a Ponticelli. C’era Draman, un ottimo musicista che di solito aveva sempre voglia di suonare, con i djembè muti fra le gambe senza. C’era la birra che passava di mano in mano. C’era un calore e un affetto in quella casa, oltre al dolore, che contrastavano con il buio della notte e con le costruzioni malridotte del piccolo quartiere. Ho ricordi di sorrisi e di chiacchiere fatte all’associazione «N:EA», di persone incontrate e per timidezza poco coltivate. Ho il ricordo della pagina della rivista Caffè che riempimmo con le scritture del laboratorio di scrittura migrante. Per quanto varia fosse la presenza straniera nella nostra esperienza d’allora, non ancora prefigurava l’affluenza straniera iniziata dopo il 2000, modificata e aumentata nel numero e per nazionalità e strutturata sul territorio in una geografia variabile e complessa da riconoscere. Oggi, mi racconta Jamal allo sportello stranieri della Cgil in via Torino, ci sono 67.000 immigrati a Napoli. Sono ormai lontani gli anni Settanta in cui l’unica e prima presenza storica in città era costituita dagli eritrei fuggiti alla guerra costituiti in comunità nei Quartieri Spagnoli. E’ stato con gli anni Ottanta che gli arrivi hanno iniziato a farsi massicci: prima capoverdiani e filippini, impiegati quasi sempre in lavori domestici, status symbol nelle case dell’alta e media borghesia napoletana, accolti da una normativa del tutto impreparata (il testo unico del 1931: la prima circolare emessa riguarda proprio la collocazione del lavoro domestico) e poi sandomenicani, etiopi quasi sempre impiegati in lavori precari. Tunisini e marocchini si occupano, invece, solo di lavori stagionali: metà dell’anno in Italia, l’altra metà nei paesi d’origine. Si susseguono fra il 1986 e il 2002 cinque sanatorie per far fronte al fenomeno della migrazione. Dalla Nigeria, dal Ghana e dalla Costa d’Avorio chi arriva è impiegato in lavori saltuari: ogni gruppo che arriva occupa sempre e solo una singola fetta del mercato, specializzandosi in essa, sia che si tratti di lavoro regolarizzato, sia che lavori al nero. Con gli anni Novanta una nuova ondata di arrivi si profila: chi viene dall’Algeria apre in città numerosi ristoranti intorno a Piazza Garibaldi, fra via Torino e via Bologna (e la comunità algerina, benché non organizzata, rimane una delle presenze maggiori per numero in città: nei ristoranti intorno alla Stazione Centrale mangiano tutti i musulmani, di qualsiasi provenienza geografica, si aprono macellerie e spacci ad hoc). Chi viene dallo Sri Lanka è impiegato da sempre nei lavori domestici ma è con l’arrivo dei polacchi, e dopo degli ucraini (presenze quasi sempre declinate al femminile), che cambia l’ordine di importanza (numerica) delle comunità napoletane. Gli arrivi dall’est europeo sono imponenti e si concludono con l’ingresso degli albanesi, solitamente impiegati in autolavaggi o in lavori precari. Insomma, la tendenza che portava in città prevalentemente studenti del bacino del Mediterraneo, greci e mediorientali, molti dei quali sono oggi architetti, farmacisti, insegnanti, sindacalisti, si modifica del tutto per numero e provenienza. E’ la legge Turco-Napolitano del ’98 che corrisponde all’aumento e alla diversificazione delle presenze: somali, eritrei, senegalesi, bulgari, ucraini. Ma è la Bossi-Fini che fra ’98 e 2002 fa crescere la presenza delle ucraine, in particolare, regolarizzandone moltissime. Le collocazioni delle comunità sono eterogenee: i capoverdiani abitano in città, fra Piazza Cavour e Piazza Dante, ma lavorano nelle case di Posillipo; gli eritrei nei Quartieri Spagnoli (dove si apre il ristorante di cucina eritrea Mar Rosso). Chi viene dallo Zaire o dalla Liberia o dal altri paesi centro-africani lavora stagionalmente e risiede fra Giugliano e Lago Patria. I nordafricani sono presenti su tutto il territorio e in Campania diventano stanziali anche nei paesi più piccoli e dispersi, nel casertano, nell’avellinese, nel beneventano. L’evento di svolta è certo nel 1989 la morte di Jerry Maslo, a Villa Literno: la manifestazione che ne consegue, organizzata anche dalla Cgil, porta i politici italiani su un territorio che da decenni soffre di incuria e mancanza di servizi, di camorra e degrado, fenomeni che la presenza di lavoratori stagionali stranieri amplificano. La legge Martelli nasce come immediata conseguenza nel dicembre ’90. Ucraine e polacche si affollano con la fine degli anni Novanta in città e nell’immediata provincia e periferia: sono badanti e la loro presenza nelle case non è più questione di status symbol ma necessità estesa e trasversale alle diverse classi sociali. Non c’è famiglia che non abbia o stia cercando una badante per anziani, malati, bambini. Le comunità dell’est hanno una grossa presenza residenziale fra Giugliano e San Giuseppe, e nel vesuviano in genere, ma sono un po’ ovunque: di 32.000 stranieri regolarizzati nell’ultimo anno ben 22.000 sono badanti. I cittadini immigrati, attualmente, sono impiegati in ogni settore: l’edilizia, il settore tessile, i servizi (intesi in senso ampio) e nelle fabbriche. Se fino a qualche anno fa le comunità erano 7, oggi se ne contano 15 e l’area vesuviana e i Campi Flegrei ospitano indifferentemente cingalesi, eritrei, somali, polacchi, ucraini, bulgari. Rimane fermo però il dato che la maggioranza degli immigrati è donna: nella comunità dello Sri Lanka il 70% è femminile ed impiegato in lavori domestici, ma anche il restante 30 % maschile è impiegato nello stesso settore. L’unica comunità a prevalenza maschile è quella islamica impiegata nel settore dei lavori precari: senegalesi, tunisini, marocchini si occupano di commercio, da quello regolare alla bancarelle, aprono ristoranti e negozi di artigianato intorno a Piazza Garibaldi. Indiani, pakistani e cittadini del Bangladesh – la comunità di questi ultimi ha sede a Palma Campania – sono impiegati nel settore tessile fra lavanderie e sartorie di Afragola e Frattamaggiore, o, ancora, in piccole fabbriche di vernici e auto. Ghanesi e ivoriani lavorano negli autolavaggi della periferia urbana ma aprono anche negozi di bigiotteria che fanno interfaccia con negozi napoletani, importano ed esportano: su Via Bologna il mercato interetnico, regolarizzato e legalizzato, aperto ogni giorno dalle 8.30 alle 15, è un esperimento felice di commercio ma anche di scambio interculturale. Resta infine da considerare la presenza cinese: i primi arrivi nel ’92 con l’apertura di 25 ristoranti sono poi esplosi nel ’96. Gli arrivi da Prato vedevano i cinesi impiegati soprattutto nel settore tessile napoletano dell’area vesuviana, fra San Giuseppe, Ottaviano e San Gennariello, ma la condizione è subito precipitata per la conversione di questo lavoro, regolarizzato anche se mal pagato, in industrie di gestione cinese dove i lavoratori versano in condizioni estreme e sono pagati al nero. Un intero settore, dalla produzione alla distribuzione, è ora gestito dalla sempre più ampia comunità cinese che tende a diventare indipendente. E il panorama tende a diventare sempre più complesso: Napoli non è più città di passaggio, ma metropoli di residenza multiculturale.
(1 – continua)
Antonella Cilento – IL MATTINO 4 GIUGNO 2005