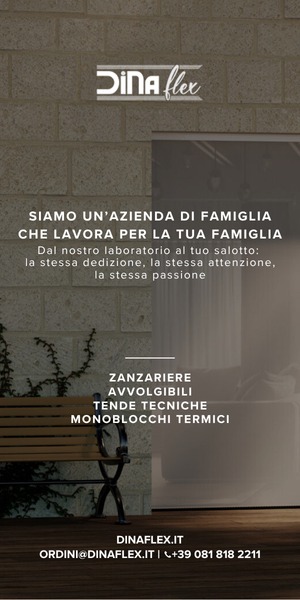«La città finge disinvoltura. Ma in realtà c’è ansia. Ogni volta che qualcuno viene da fuori,
che viene a prendere possesso della piazza del paese, ogni volta che si parla di qualcosa
di cui non si vuole parlare l’aria diviene come rarefatta. Grumosa. Mancavo da un
anno, e tutto sembra identico a Casal di Principe. I politici nazionali non la frequentano
molto. La conoscono per voci lontane. Ogni tanto finisce in qualche statistica: la città con più
Mercedes al mondo, quella con più omicidi d’Europa. Ma sembrano record del passato. Ora tutto
è cemento, rifiuti, mozzarelle. Terra dove ci sono più imprese edili che cittadini. Salgo sul palco
e sento la vicinanza di molte persone, molte venute da fuori, e molte del paese che non ne
possono più. Dei clan, del loro paese associato ai clan.
In piazza le saracinesche e le finestre sono chiuse. Il lunedì c’è riposo, dicono per giustificarli,
non è per timore dei clan che i negozi sono chiusi. Ma nessun commerciante avrebbe rifiutato
di triplicare le proprie vendite.
Vedo arrivare Renato Natale, l’ex sindaco. E’ strano. Quando glielo racconto non ci crede. Da
adolescenti nella testa di molti c’era il mito del Che. Io avevo lui come eroe. Proprio mentre lui
era sindaco uccisero Don Peppino. L’esecuzione del parroco che scrisse un documento «per
amore del mio popolo non tacerò». Non tacere, parlare: proprio quello che in queste ore sembra
essere così difficile, pericoloso. Renato Natale tentò di combattere con gli strumenti da amministratore
l’impero di cemento dei clan, iniziando dal paese, da quello che loro ritenevano il feudo.
Una volta gli scaricarono davanti a casa chili di merda di bufala. E quando decise di chiudere
con paletti Piazza Mercato, ritrovava i paletti davanti al portone sradicati dalle ruspe dei clan. Lui li rimetteva e i clan li
sradicavano di nuovo:
una simbolica guerra
che durò tempo. Ma ce
la fece. La piazza divenne luogo
di ritrovo dei giovani di tutta la
zona. In quella piazza vi fu il raduno
straordinario della popolazione
di Casale insieme a centinaia
di scout provenienti da
tutta Italia per il trigesimo della
morte di don Peppino Diana.
Le prime ragazze in strada persino
abbracciate ai propri fidanzati,
le prime donne davanti
ai bar: cose che sembrano ridicole,
semplici, normali ma
che quindici anni fa erano assolutamente
impensabili. Qui
niente è scontato. Renato Natale
mi saluta e vedendolo, proprio
mentre sono sulla piazza,
mi salgono come un doloroso
rigurgito i ricordi di episodi terribili.
Antonio Cangiano vicesindaco
di Casapesenna rifiutò
di far vincere a un’impresa di
un clan un appalto nel paese,
loro che vincevano gare in ogni
parte del nord Italia. Gli spararono
alla schiena costringendolo
per sempre sulla sedia a
rotelle. E poi Federico. Federico
Del Prete, sindacalista. Aveva
iniziato a denunciare con
un’azione costante i crimini
minuscoli, le estorsioni agli
ambulanti. E poi aveva persino
aperto un’indagine che permetteva
di vedere in alcuni
esponenti del corpo dei Vigili
Urbani il vero strumento utilizzato
dalle cosche per controllare
il territorio: dall’estorsione al
controllo dei cantieri. Era riuscito
a far vedere ciò che sino ad
allora era parso indimostrabile.
E in un momento in cui si discuteva
delle troppe macchine
blu date a sottosegretari e ministri,
Federico Del Prete lo andarono
a trovare nel suo ufficio.
Non aveva protezione. Era al telefono
quando 6 proiettili calibro
7,65 lo uccisero. E’ la storia
di un’Italia resistente le cui lapidi
sono portate nella voce di
chi ricorda questi episodi, e li
passa di bocca in bocca, mentre
mi chiedo come mai in questi
giorni, in queste ore, i governi,
questo governo abbiano davvero
fatto così poco.
C’è il padre di Don Peppino
Diana, i visi di molte ragazze del
paese che mi stringono la mano
e mi abbracciano. Mentre si avvicinano,
mi viene spontaneo
guardare dietro le loro spalle
per vedere se ci sono i loro fidanzati
e salutare anche loro
per rassicurarli sulla mia correttezza.
Sulla mia sinistra i ragazzotti
di sempre. Soliti modi
di fare. Occhiali, vestiti che se
fosse passato qualsiasi pubblicitario
o stilista li avrebbe immediatamente
presi come testimonial
dei propri prodotti.
Mi guardano gli anelli che indosso.
Li indossano anche loro.
Tre, simbolo lontano. Padre figlio
e spirito santo. E l’anello
dello spirito santo è quello della
sinistra, la mano che si da a
colui al quale non si concede rispetto.
Le telecamere non riescono
a non riprenderli. Loro si
avvicinano, «abbassa ‘sta cosa
», mettono le mani sugli
obiettivi.
Per molti che vengono da fuori è come arrivare in uno
strano luogo, quasi magico. Ciò
che fuori è cinema e delirio, qui
è realtà. Le misure di sicurezza
sono imponenti, mi dicono che
ci sono persino i cecchini: che
ad una manifestazione pubblica
in una piazza debbano esserci
i cecchini è difficile spiegarlo
in Europa. I ragazzi della mia
scorta sono tranquilli, non
hanno chiesto nessun rafforzamento
e mi placano con una
frase che non ho più dimenticato,
«noi non dobbiamo mica fare
paura a nessuno, perché nessuno
ci fa paura».
C’è una scena quasi divertente.
Ogni volta che sibilo parola o
qualcuno accenna a qualcosa
che possa somigliare al suono
del mio nome, i ragazzotti annodano
le braccia subito, di
scatto. Prima ciondolanti, con
le mani nelle tasche dei jeans e
i polsi piegati in avanti. Poi, appena
mi viene data la parola,
scattano. Come soldatini. Tutti
a braccia conserte, come a dimostrare
che non c’è un solo
applauso. Neanche l’intenzione
di avvicinare un palmo all’altro.
La dimostrazione che
nessuna sorta di vicinanza è
possibile tra loro e questo giullare.
Questo buffone.
Fausto Bertinotti parla, ma
un gruppetto inizia a disturbare.
Urlano tra loro, cominciano
a applaudire dichiarazioni che
rilasciano alle telecamere i più
maturi tra gli imprenditori presenti.
«La camorra non esiste»
urlacchiano, dichiarano ai
giornalisti e alle telecamere.
Sembra una provocazione. A
leggerla senza capire, come
una frase pronunciata da
chiunque sembra ridicola, persino
scontata. Nelle barzellette
i mafiosi dicono che la mafia
non esiste. Ma non è così. Camorra
è una parola che non
sopportano, sa di crimine comune,
quello che loro individuano
a Napoli. Rapinarolex,
ladri d’auto. Qui c’è imprenditoria,
investimento. I clan di qui
costruiscono l’Emilia Romagna,
investono in Romania, si
comprano Casinò in molte parti
del mondo, e alberghi, e commerciano
nel burro e nelle bufale,
nei trasporti e nei rifornimenti
di carburante. Dov’è la
camorra? I soldi del racket e del
narcotraffico sono fatti con
metodo aziendale, qui si è svolta
la più grande truffa alle assicurazioni
d’Italia. L’estorsione
è una partecipazione all’economia
dei clan da cui poter dopo
aver pagato ricevere benefici,
prestiti, protezioni con le
banche.
Dov’è la camorra? E’ un invenzione.
La tesi dei loro avvocati
è sempre la stessa da anni.
Qui ci sono solo imprenditori
accusati di mafiosità da concorrenti
sleali. E il sangue? Anche
per questa domanda c’è
una risposta. Vecchi rancori familiari
risolti con sparatorie,
retaggi di una terra isolata. Sento
che ciò che più ha infastidito
degli interventi è la parola «imprenditori
». Arricreatele persone
raccontandogli dei guaglioni
con la pistola, ma non toccate
gli affari.
In piazza c’è don Nicola, il padre
di Francesco Schiavone, il
boss dei Casalesi divenuto celebre
per il soprannome Sandokan,
e per la sua capacità di settore del cemento con una disciplinata
ferocia: dall’alta velocità
alle grandi ristrutturazioni,
in grado di nascondersi da
latitante al centro di Casal di
Principe mentre le polizie di
mezzo mondo lo cercavano.
Don Nicola non lo riconosco
subito, è parecchio invecchiato.
Pensavo ci sarebbe stato ad
accoglierci suo nipote che porta,
come legge di sangue pretende,
il suo stesso nome, anche
lui ormai chiamato don Nicola.
Il figlio maggiore di Sandokan.
Ma non c’è. Don Nicola
mi definisce un pagliaccio, un
buffone denigratore della propria
terra. Accuse necessarie,
ovvie. Non è pensabile essere
accolto a braccia a aperte. «Cosa
hai fatto nella vita? Solo denigrare
la tua terra», mi viene detto.
E anche questo è un pensiero
di molti. Ma che il vecchio
padre di Sandokan esclama
senza pudore.
E poi l’accusa più atroce:
«Quello vuole diventare deputato
». Come se ci fosse la sottile
insinuazione che si vuol divenire
potenti, pronti a chiedere favori
e a darne. A spartirsi le torte
e i territori. Ai clan fa schifo la
politica, è solo lo spazio che può
essere o ignorato o usato. Nelle intercettazioni chiamano i politici
che sostengono in campagna
elettorale «cavallucci da
mandare a governare». Don Nicola
vuole salire sul palco. Anche
lui vuole parlare. I giornalisti
venuti da fuori sono sconvolti.
Come ogni forma di tragedia
in alcuni momenti assume i
contorni della commedia così
viene voglia di ridere, vedendo
questo anziano signore che
chiede di parlare. Avrei voluto
che gli fosse data la parola:
avrebbe decantato la sua terra
come ricca e florida, ma denigrata
da buffoni e cialtroni in
cerca di visibilità. Ed è questo
uno dei miracoli della terra di
camorra. Creare una specie di
soddisfazione continua nella
propria quotidianità e verso la
propria terra. Al punto tale che
il clan di Casal di Principe prende
il nome degli abitanti. Casalesi.
Un nome che pronunciato a Napoli mette paura, da Secondigliano
a Marano. E persino
in Sicilia. Degnano di alleanza
solo le ‘ndrine più ricche. In
Italia due clan prendono il nome
dai loro paesi identificandosi
quindi con essi. I Casalesi e
i Corleonesi.
Quando i cronisti si avvicinano
a capire gli umori dei cittadini,
in ogni zona d’Italia la gente
impreca, e si danna il cielo e gli
amministratori, si insultano
tasse e traffico, la mancanza di
lavoro. Invece per magia in terra
di camorra tutto questo muta.
«Qui stiamo bene, andatevene
». E’ la prima cosa che dicono
coloro che in piazza si definiscono
imprenditori. «Ma
quale camorra, noi stiamo benissimo.
La camorra la inventate
voi. «
Non è a me che sta parlando
don Nicola Schiavone. Non è al
Presidente della Camera e
neanche al Presidente della
Commissione Antimafia. Don
Nicola e i ragazzi di Schiavone
stanno parlando alla loro gente,
stanno parlando alle altre famiglie
della confederazione dei
Casalesi. E’ ai clan che in realtà
stanno mandando messaggi.
Pochi se ne accorgono. Don Nicola
e i suoi stanno dicendo alle
altre famiglie che loro non si
fanno scalciare, stanno cercando
di difendere la loro leadership,
gli Schiavone sono ancora
loro i capi formali.
Non si prendono gli schiaffi
in volto senza reagire. Circoscrivono
la piazza da lontano,
come a dire: qui siete venuti in
una sorta di riserva, ora che ve
ne andate noi restiamo.
Quando me ne sto per andare
molti ragazzini intorno all’auto
della mia scorta si raggruppano.
Visi ancora abbronzati,
solito ghigno. «Bello il romanzo
che hai scritto». Dicono.
Tenendo forte la carica sulla z.
Come se la parola romanzo insultasse
il libro. E poi ridendo
«Proprio nu’ bellu romanzo».
Romanzo, sinonimo di invenzione,
storiella, fesseria. Non
può contenere verità né nomi e
cognomi, e indirizzi e sangue.
La cosa più inutile e inventata
hai fatto: un romanzo. L’inutile.
Un inutile che compravano
di nascosto, o sbirciavano in
singole pagine dove i loro capizona
venivano raccontati. Forse
persino per sapere o capire
quello che le leggende di paese,
che creano boss come sovrani,
non gli raccontavano.
E’ come quando un anno fa,
sempre a Casal di Principe, subito
dopo il mio intervento in
cui invitavo i ragazzini delle
scuole a cacciare i boss dalle loro
terre: «Ma come, tu non facevi
lo scrittore?». E cercano di
trovare pace valutando i mestieri.
E’ dai giudici, da certi giudici
che bisogna aspettarsi carognate,
è da alcuni politici arrivisti
che bisogna aspettarsi
comportamenti infami. Ma dagli
scrittori proprio non c’è da
temere. Se questo accade è perché
divengono buffoni, giullari,
come se davvero credessero
che le parole, le loro parole,
quelle degli scrittori usate per
mestiere e quindi solo di convenienza
secondo loro, possano
mutare le cose.
La giornata è finita. La macchina
con i miei ragazzi mi porta
fuori, costeggiamo le terre
marce di diossina, dove si viene
spesso educati troppo spesso
come in una sorta di Sparta. Un
senso di impotenza ti pervade:
anche se sembra che nulla sia
mutato, in realtà molto, molto è
pronto per cambiare, attende
che sia dato spazio alla mutazione.
Piccoli dettagli che non
possono essere ignorati. Persino
il fastidio per la presenza
istituzionale può lasciar sperare:
troppo spesso lo Stato ha fatto
promesse senza mantenerle,
è venuto un giorno e se n’è andato
il giorno dopo.
Quand’ero ragazzo, prima di
fare a pugni, prima di sentire le
nocche sulle gengive e prima
che ci si rotolasse per terra cercando
di bloccare con le gambe
a tenaglia le cosce di chi stavi
sfidando, ci si sfidava a parole.
Ecco, mi ricordo che prima di
fronteggiarti, le frasi di rito erano
degne di uno scontro tra cavalieri,
che ad ascoltarle ora farebbero
ingolfare la gola di risate.
Ma le ricordo ancora: «Io
vengo da dove si imparano due
cose, a sputare in faccia alla
morte e alla paura. Sappi che
per me vita e morte sono la stessa
cosa». E sento solo ora cosa
avrei voluto dire, viso a viso, a
molti di quei ragazzi; che io ho
imparato a risparmiare la saliva,
che vita e morte non sono la
stessa cosa e che fino al termine
di questa notte proseguirò questo
viaggio. Non datevi pace».
ROBERTO SAVIANO
La Repubblica 19 settembre 2007
http://download.repubblica.it/pdf/2007/r2.pdf