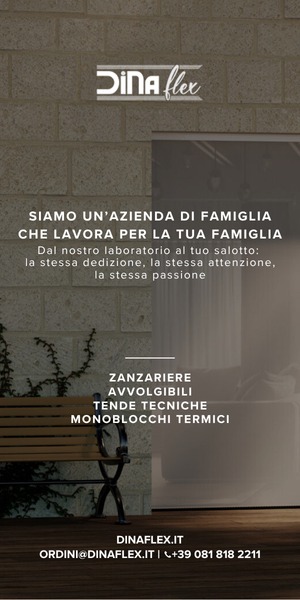Il caporalato non riguarda soltanto l’agricoltura, da tempo è entrato anche nel mondo della moda italiana, un settore che nel racconto ufficiale si regge su artigianato, eccellenza e qualità. Dietro molte etichette “Made in Italy” si nascondono invece turni estenuanti, paghe ridotte e laboratori nascosti, una realtà che contrasta con l’immagine di lusso e perfezione.
Cos’è davvero il caporalato nella moda
Per caporalato si intende qualsiasi sistema di reclutamento e sfruttamento della manodopera attraverso paghe irrisorie, orari eccessivi e veri e propri ricatti oltre che assenza di tutele. Nella moda questo fenomeno è favorito dalla struttura stessa della produzione, composta da molti laboratori esterni e da una catena di passaggi che rende difficile controllare tutto ciò che accade.
Il modello produttivo che crea terreno fertile allo sfruttamento
La filiera del fashion si basa su una catena di subappalti. Il marchio principale commissiona una lavorazione a un laboratorio, che spesso la trasferisce a un terzista ancora più piccolo. A ogni passaggio il controllo si indebolisce. Nel frattempo i tempi di consegna diventano sempre più veloci, non esistono più solo due collezioni l’anno, ma pre-collezioni, capsule continue e ritmi imposti dalla grande produzione. La corsa alla rapidità richiede manodopera flessibile, immediata e a basso costo. Per restare competitivi, molti fornitori sono costretti a comprimere i margini e a pagarne le conseguenze sono i lavoratori degli ultimi livelli della catena, dove gli abusi possono passare inosservati.
Dalle sarte di Carpi al caso Tod’s: un fenomeno diffuso
Le inchieste degli ultimi tempi mostrano quanto lo sfruttamento sia radicato. A Montemurlo, vicino Firenze, le operaie che lavoravano per la boutique Patrizia Pepe hanno denunciato mesi senza stipendio e condizioni insostenibili. A Carpi e Reggio Emilia molte sarte impegnate nelle lavorazioni per Max Mara o Montblanc hanno raccontato turni notturni e paghe troppo basse. A Prato sono stati sequestrati laboratori trasformati in dormitori, dove si lavorava anche di notte. L’indagine più recente – quella che coinvolge Tod’s – parla di sei opifici gestiti da imprenditori cinesi, con salari minimi, alloggi improvvisati e irregolarità ripetute nel tempo.
Napoli e il peso della filiera nascosta
Anche Napoli è parte di questo sistema. La città e la sua provincia ospitano da decenni una rete di laboratori di pelletteria, confezione e lavorazioni a domicilio. Questa struttura produttiva, fondamentale per molte aziende italiane, è però anche vulnerabile. Dove il lavoro rimane sommerso, dove non ci sono contratti e dove la competizione spinge i prezzi sempre più in basso, il rischio di sfruttamento cresce. È un pezzo di Made in Italy che resta nascosto, ma che sostiene una parte importante del settore moda.
Il DDL PMI e lo “scudo penale”- la Campagna Abiti Puliti lancia l’allarme
In questo contesto arriva il discusso DDL PMI, il disegno di legge dedicato alle piccole e medie imprese. Il testo introduce una certificazione volontaria della filiera, presentata come strumento di tutela. Secondo la Campagna Abiti Puliti, però, questa misura rischia di trasformarsi in uno “scudo penale” per i marchi più grandi. Se la certificazione non è obbligatoria e non prevede controlli rigorosi, le aziende committenti possono dichiararsi conformi senza verificare davvero cosa accade nei laboratori esterni. La responsabilità si attenua, mentre la parte più debole della filiera rimane scoperta.
Una certificazione volontaria serve più ai brand che ai lavoratori. Senza un obbligo di vigilanza reale e senza una due diligence che attribuisca responsabilità lungo tutta la filiera, il rischio è quello di creare una bella facciata dietro cui continuano a esistere gli stessi problemi di sempre. In pratica il Made in Italy apparirebbe protetto, ma solo sulla carta.
Il valore reale dei prodotti e il ruolo dei consumatori
Ogni capo non è solo un prodotto è il risultato del lavoro di chi lo realizza. Se quel lavoro avviene in condizioni di sfruttamento, il valore del prodotto si svuota, anche quando porta un’etichetta prestigiosa. La moda vive di narrazione ma nessuna narrazione può essere credibile se nasconde la parte più fragile della filiera. Per difendere davvero il Made in Italy servono regole chiare, controlli severi e responsabilità condivise tra aziende, istituzioni e consumatori.